|
EMIGRAZIONE, UN DRAMMA ANTICO
GIUSEPPE AGOZZINO
L'artista
Giuseppe Agozzino
aggiunge ai precedenti lavori dedicati ai
derelitti cantati da De André di alcuni anni fa, questa raccolta di lavori
sul drammatico problema degli immigrati.
articolo critico di Nicolò D'Alessandro
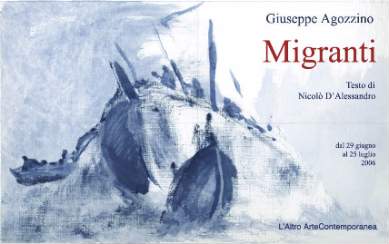
Un secolo fa, il
6 agosto del 1906, il vapore Sirio con 2.000 emigranti diretti in America
partiva dal porto di Genova. Vicino alle coste spagnole, tre giorni dopo, urtò
accidentalmente contro uno scoglio che si trovava a circa 3 metri di
profondità e cominciò un lento inabissamento. La nave impiegò venti giorni
per affondare definitivamente ma la disorganizzazione e la paura presero il
sopravvento e, secondo i giornali dell’epoca, finirono annegate oltre 700
persone. Il tragico naufragio del vapore Sirio è ricordato in una ballata
molto diffusa in tutto il nord Italia:
“E da Genova il
Sirio partivano
per l’America, varcare, varcare i confin.
Ed a bordo cantar si sentivano
tutti allegri del suo, del suo destin.
Urtò il Sirio un orribile scoglio
di tanta gente la mise, la misera fin.
Padri e madri bracciava i suoi figli
che si sparivano tra le onde, tra le onde del mar.
E tra loro un vescovo c’era dando a tutti
La sua be, la sua benedizion.”
Ancora da “Ci
ragiono e canto”, regia di Dario Fo (1966) voglio ricordare un brano
popolare, raccolto nel Casentino, che allude alle condizioni di:
“30 giorni di
nave a vapore
che nell’America noi siamo arrivati
e nell’America che siamo arrivati
abbiam trovato né paglia e né fieno
abbiam dormito sul piano terreno
e come bestie abbiamo riposà.
America allegra e bella
tutti la chiamano l’America sorella.
Ci andaremo coi carri dei zingari
in America voglio andar.
E l’America l’è longa e l’è larga
l’è circondata di monti e di piani
ma con l’industria dei nostri italiani
abbiam fondato paesi e città.”
Queste due
ballate scritte a distanza di sessanta anni l’una dall’altra, sottolineano
che gli italiani sono andati in giro per il mondo poveri, ignoranti, malvisti
come lo sono ora i migranti che vengono da noi. Alcuni di loro non sono mai
arrivati ai luoghi di destinazione.
L’emigrazione
italiana
Molti
ricorderanno che la gran parte dell’emigrazione italiana deriva dall’antico
Stato indipendente e sovrano del Regno delle Due Sicilie. Nel 1860, senza
dichiarazione di guerra, il Regno piemontese dei Savoia occupa militarmente il
Regno delle Due Sicilie. Seguono dieci anni di guerra civile, durante la quale
vengono assassinati circa un milione tra Napoletani e Siciliani. L’intero
patrimonio monetario è rapinato dalle casse dello Stato delle Due Sicilie e
perfino i macchinari delle fabbriche napoletane sono portati al Nord dove in
seguito sorgeranno le industrie del Piemonte, della Lombardia e della Liguria.
La depressione economica causata dalle politiche colonizzatrici dell’”Italia
unita” fece il resto. Per i meridionali l’unica via di salvezza rimase l’emigrazione.

Gli italiani,
come è noto, sono stati protagonisti del più grande esodo migratorio della
storia moderna conosciuta. A partire dal 1861, nell’arco di un secolo, sono
state registrate più di ventiquattro milioni di partenze, un numero che
equivale all’ammontare della popolazione italiana al momento dell’Unità.
Rileggendo i dati statistici del periodo ci accorgiamo che si trattò di un
esodo che interessò tutta la penisola, con priorità nel settentrione. Il
Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Piemonte, tra il 1876 e il 1900,
espressero quasi il 50 per cento del fenomeno migratorio. La situazione si
capovolse nei successivi venti anni. Il primato migratorio passò alle regioni
meridionali: la Campania con 9.551.889 emigranti e la Sicilia con 1.126.513.
Negli anni
1890-1913, su dieci siciliani emigrati, nove si recarono negli Stati Uniti.
Negli anni 1950- 60 dei 400.000 siciliani emigrati circa il 25 per cento
preferì mete transoceaniche: Oceania, Africa e Asia. Gli altri si dispersero
verso le regioni industrializzate del Centro Nord italiano, verso i paesi del
Nord dell’Europa e verso i paesi non europei del bacino del Mediterraneo.
Siciliani in
America
In origine
Gibbet Island veniva usata dagli inglesi per confinarvi i pirati e poi come
deposito di munizioni. A New York il centro d’accoglienza degli italiani ad
Ellis Island, un isolotto di fronte a Manhattan, dal 1894 divenne stazione di
smistamento per gli immigranti quando ne fu necessario il controllo per il
massiccio afflusso. Ammassati negli edifici di Ellis Island o di altri porti
come Boston, Baltimora o New Orleans gli immigrati, dopo settimane di viaggio,
affrontavano l’esame, a carattere medico e amministrativo, dal cui esito
dipendeva la possibilità di mettere piede sul suolo americano. La severità
dei controlli fece ribattezzare l’isola della baia di New York come l’”Isola
delle lacrime”. Vennero chieste cifre elevate per il trasporto dalla Sicilia.
Numerosi furono gli episodi di gruppi di immigrati abbandonati in mare aperto o
sulle coste. A questo proposito penso al racconto “Il lungo viaggio”di
Leonardo Sciascia in Il Mare colore del vino in cui gli emigranti, fatti
salire su una nave con destinazione americana vengono poi sbarcati sulla costa
siciliana dopo aver circumnavigato per diversi giorni l’isola.

La “casa di
prima accoglienza-prigione” rimase attiva fino al 1954, quando fu chiusa e
abbandonata. Oggi è divenuta un museo, ma migliaia di italiani sono passati
per la grande Sala di Registrazione a Ellis Island. ”Uccelli di passaggio”
vennero definiti gli immigrati in America in quanto il loro intento era di
andare solo per qualche anno: molti infatti lasciarono a casa mogli e bambini,
convinti di ritornare.
Il fenomeno non
si esaurisce
La questione
dell’inserimento e delle trasformazioni culturali legata ai fenomeni
migratori è un problema con il quale, non soltanto in Sicilia, bisogna fare i
conti. Il fenomeno migratorio che si è sviluppato nel mondo negli ultimi vent’anni
è determinato dalle profonde trasformazioni indotte dalla terza rivoluzione
industriale in atto che sta spostando la popolazione mondiale verso i centri
delle regioni protagoniste della nuova grande trasformazione. L’esistenza di
un multiculturalismo e dell’intercultura costituiscono un problema che non è
valutato in tutta la sua complessità. L’esperienza migratoria italiana
presenta molti elementi comparabili all’attuale immigrazione e alle dinamiche
dell’inserimento nella società di accoglienza. Non è semplice combattere
gli stereotipi e i pregiudizi, le facili generalizzazioni che accompagnano tali
fenomeni. Le merci possono entrare liberamente nel mercato; agli uomini che
tentano disperatamente di “entrare” con la speranza di una vita migliore è
negata invece la libera circolazione.
Le tempere di
Giuseppe Agozzino
L’attenzione
del pittore agrigentino, in queste tempere monocromatiche quasi di impianto
sironiano, di gusto illustrativo, con prevalente colore “grigio topo” e la
memoria di un bleu sporco, è rivolta al tema complesso ed ancora irrisolto
dell’immigrazione.

Si conferma la
passione civile in Giuseppe Agozzino che, ai precedenti lavori dedicati ai
derelitti cantati da De André di alcuni anni fa, aggiunge quest’ultima
matura raccolta di lavori dedicati al drammatico problema degli immigrati.
Tutti extracomunitari, tutti ad Agrigento, ad aspettare il rimpatrio coatto.
Alcune tavole mi riportano a quella sensibilità rappresentativa e popolaresca
che ben conosco. Mi riferisco agli ex voto della Chiesa di San Calogero ad
Agrigento. Tra queste tavolette votive ne ricordo con chiarezza alcune dedicate
ai naufragi e ai miracolosi salvamenti del santo agrigentino amato dagli
abitanti di Agrigento nonostante il patrono sia San Gerlando.
Un percorso
narrativo
I soggetti
scelti dal pittore agrigentino sono tratti da ritagli di giornali o da alcune
fotografie di Lillo Rizzo che rappresentano il documento che registra una
tragedia quotidiana.
Alcuni disegni
ben rappresentano gli accerchiamenti dei barconi dei disperati di questi “viaggi
dell’angoscia”. Salvagenti in rosso sono evidenziati attorno alle carrette
del mare che trasportano gli immigrati, mentre imbarcano acqua.
In un altro
disegno dall’alto scendono le forze dell’ordine, in bell’ordine, mentre
da lontano arrivano anonimi clandestini al porto o nelle coste dell’agrigentino.
Non conoscono sosta gli arrivi di immigrati sulle coste siciliane. Sempre nuovi
sbarchi avvengono dopo estenuanti traversate.
Dai pescherecci
si buttano in mare gli uomini per raggiungere, nuotando disperatamente, la
condizione di clandestini senza futuro. Alcuni cadaverini, corpi morti
galleggianti vagano nel mare di tempera bianca. Ci restituiscono con amara
ironia la sensazione di “fare il morto” a pancia in su e a braccia distese,
come siamo soliti vedere d’estate nelle stesse coste appaltate dall’industria
turistica.
A proposito di
morti come dimenticare che nel Natale del 1996, 286 migranti dallo Sri Lanka
morirono nel Canale di Sicilia. Ci vollero anni solo perché i superstiti
fossero creduti e intanto il mare restituiva resti umani che nessuno aveva
interesse a considerare tali. In un’altra temperina altri clandestini
riposano come possono avvoltolati nelle coperte e nei plaids. Di fatto sono
reclusi in attesa di essere identificati nel Centro di Permanenza Temporanea S.
Benedetto ad Agrigento. Li chiamano centri di permanenza temporanea e
assistenza. E sono il segno di un diritto separato, punitivo, nei confronti
degli immigrati.
Le frontiere non
fermano chi ha fame. “Nessuno può fermare persone che hanno paura e che
fuggono dalla fame e dalle guerre”. Il centro di accoglienza temporanea di
Lampedusa, chiamata “l’isola degli arrivi” può ospitare solo una
novantina di persone. Continuano gli sbarchi nell’isola, ed i centri di
permanenza sono stracolmi.
Gli immigrati
avvistati al largo a bordo di barconi sono affiancati da motovedette della
Guardia costiera e della Guardia di finanza, unità della Marina Militare le
quali provvedono al loro trasbordo presso i centri di accoglienza di Lampedusa
e infine a Porto Empedocle-Vigata.
Scene molto
tristi appaiono agli occhi dei curiosi. Gli ospiti non hanno voce, hanno solo
un volto. Regolarmente riprese dall’occhio implacabile delle telecamere e
commentati dai giornalisti che ormai hanno esaurito tutti i possibili commenti,
quasi sempre gli stessi e che stancamente ne riportano i volti anonimi.
L’artista
evidenzia in una tavola un cimitero di pescherecci. Altri disgraziati nuotano
verso la riva, sognando un futuro diverso. Mamme, come ultimo gesto disperato,
buttano a mare i loro bambini per salvarli. Le foto segnaletiche diventano
espressivi ritratti del dolore. In un disegno due torce elettriche illuminano
la paura con fare inquisitorio.
Con impegno
Agozzino racconta di questi rifugiati che affrontano un viaggio in mare in
condizioni difficilissime e fuggono da paesi che non riconoscono i diritti
umani e dove la popolazione soffre. Una saga, questa di Aguzzino, evocata per
immagini, come quella espressa in versi del poeta americano Edgar Lee Masters
che si proponeva di descrivere la vita umana raccontando le vicende di un
microcosmo, il paesino di Spoon River. Ci troviamo, senza alcun dubbio, di
fronte ad una bella mostra che mette l’accento su una storia feroce. Una
storia davvero brutta poiché irrisolta.
I diritti negati
nei centri di accoglienza
I centri di
permanenza temporanea e assistenza sono stati istituiti in Italia nel 1998 con
la legge Turco-Napolitano per la gestione del fenomeno migratorio. Previsti per
gli immigrati trovati in condizioni irregolari sul territorio italiano e
motivati dalla necessità di procedere ad accertamenti supplementari sull’identità
e la nazionalità degli stranieri, limitano di fatto, pur se temporaneamente,
la libertà dell’individuo anche nel caso in cui non sussistano reati penali
commessi.
La legge del
1998 diventa successivamente la base su cui verrà fatta poggiare la nuova
legge sull’immigrazione, proposta da Fini e Bossi. Essa prevede norme
particolarmente vessatorie contro questi cittadini del mondo, definiti
eufemisticamente “extracomunitari” (cioé fuori dalla comunità), costretti
a lasciare i propri villaggi, paesi, città, per sopravvivere e per assicurare
un avvenire migliore ai propri figli o familiari.
L’equazione
“clandestino-criminale” farà un altro passo avanti. Si prolungherà la
durata dell’internamento e le espulsioni diverranno più facili.
Sostanzialmente i cittadini extra-comunitari, possono essere soggetti a
custodia e privazione della libertà personale anche nel caso – puramente
amministrativo – di non possedere un permesso di soggiorno.
I centri di
permanenza temporanea sono divenuti, a tutti gli effetti, luoghi di detenzione
militarizzati, veri e propri “non-luoghi”, quasi sconosciuti all’opinione
pubblica, una terra di nessuno all’interno della quale i reclusi vagano in
attesa, da un muro all’altro, da un corridoio all’altro per sessanta
giorni, dentro metaforiche gabbie. Gabbie per uomini e donne giudicati
colpevoli di aver varcato i confini per vedere come si vive in Europa, rei di
non essere stati regolarizzati dai rispettivi datori di lavoro e di lavorare in
nero, responsabili di aver perso la loro occupazione e di non averne trovata un’altra.
Ma questi sfortunati cittadini somigliano tanto ai nostri connazionali che, per
oltre un secolo sono emigrati dall’Italia fuggendo la miseria alla ricerca di
un lavoro.
Non è difficile
ritenere che “l’aumento degli sbarchi di clandestini sia la conseguenza di
una politica di governo che non è riuscito a stipulare accordi bilaterali con
i paesi da cui provengono i flussi migratori. Ma questi clandestini-criminali
sono detenuti? Sono ricoverati? Sono nei fatti dei carcerati, figure spurie, in
strutture diverse dalle carceri.
Un nuovo
razzismo
Tutti sappiamo
che milioni di persone sono costrette a migrare continuamente, spinte dall’ingiustizia,
dalla guerra, dalla violenza verso i luoghi dove si accumulano le ricchezze.
La legge
Bossi-Fini è stata scritta senza tenere conto che la storia marcia
indisturbata verso la globalizzazione. Una scelta politica che vuole tutti
schedati come se migrare fosse un crimine senza comprendere le singole storie
di fuga e le loro ragioni individuali. Chissà se dire addio alla famiglia,
alla propria casa e agli amici, partire per un paese straniero senza conoscerne
la lingua e con pochissimi soldi, senza conoscere nessuno, significhi qualcosa
per i legislatori. Il rischio è di legittimare un’immagine dello straniero
come di un soggetto pericoloso o di un potenziale delinquente. Diventeranno
questi uomini disperati i senza nome, gli invisibili, persone anonime pronte a
sopravvivere con qualunque mezzo, schiavi delle raccolte stagionali di frutta e
verdura e sfruttati ai distributori notturni di benzina, le ragazze destinate
alla prostituzione? Clandestini disperati o criminali voluti da una società
opulenta che finge di non capire!
 Leggi la biografia dell'artista e critico d'arte
Leggi la biografia dell'artista e critico d'arte
Nicolò d'Alessandro
|  Pitture
e artisti in mostra permanente
Pitture
e artisti in mostra permanente
 Pitture
e artisti in mostra permanente
Pitture
e artisti in mostra permanente